La Guerra e I Rifugi Antiaerei - Da “Un Cieco che Vede” del prof. Antonio Greco
Antonio Greco Aggiornato il 24/03/2021 08:00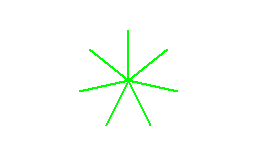
Quell'anno tornammo in famiglia ai primi giorni di giugno. Rocco non era in casa, perché era stato chiamato al servizio militare già dal mese di febbraio. Ripresi la mia vita di contadino: trascorrevo il giorno in campagna e la sera tornavo al paese. Accanto al nostro podere spesso veniva condotto un gregge per il pascolo. Il pastorello, Pasqualino, era un vicino di casa ed amico. Mi piaceva fargli compagnia per conoscere meglio gli animali a cui ero molto affezionato. Mi divertivo a toccare le pecore e il montone che aveva delle corna lunghe nell'insieme più di 60 centimetri. Al ritorno a casa ci divertivamo a cavalcarlo, giacché eravamo ancora ragazzini, e ci sembrava di imitare i grandi cavalieri. Pasqualino possedeva anche un'asina di Martina e, quando i suoi familiari venivano in quel podere accanto al nostro per lavori vari con l'asina, la sera , al ritorno a casa, cavalcavamo tre o quattro di noi su quella bestiola.
Intanto il tabacco, dopo le messi, cominciava a maturare e quindi bisognava sfrondarlo. Era ormai cominciato il suo estenuante Lavoro. Bisognava raccogliere le foglie dall'alba fino alle otto o nove del mattino e poi, al fresco nell'unica stanza disponibile, bisognava infilzarlo nello spadino e costruire le filze che, a sua volta, venivano stese su telaietti di legno, più di due metri di lunghezza e quasi un metro di larghezza. Si potevano appendere dalle 16 alle 18 filze per ciascuno, e poi si esponevano al sole ad essiccare.
Bisognava vegliare di giorno e di notte, per essere pronti, in caso di pioggia, a porre i telaietti o le canne con filze lunghe il doppio, al coperto. Allora i contadini non disponevano di ampi teloni in grado di coprire il tutto, come gli agricoltori di oggi. Allora la campagna richiedeva un estenuante e snervante Lavoro molto superiore alle esigenze odierne.
Io, Uccia e Narduccio, che quasi compiva quattro anni, non prendevamo parte alla raccolta delle foglie del tabacco, perché bisognava raccogliere solo quelle già mature che si distinguevano dal Colore. I miei andavano in campagna all'alba, mentre noi, con comodo, ci avviavamo verso le otto, quando il sole era già alto. Uccia faceva da mammina a Narduccio. Gli curava l'igiene e gli faceva fare colazione, giacché aveva buon appetito e cresceva forte e robusto. Già da quando aveva meno di un anno, si era costretti ad imboccarlo con due cucchiai in quanto, essendo i pasti troppo caldi, bisognava raffreddare il cibo su un cucchiaio e tenerlo pronto per alternarlo subito all'altro, se non lo si voleva sentire strillare.
Il podere distava dal paese quasi due chilometri e noi li percorrevamo a piedi. Il gran caldo già si faceva sentire, e noi facevamo brevi soste all'ombra di qualche albero, lungo il sentiero. Giunti in campagna, il nostro Lavoro era già pronto: nella stanza c'era già il tabacco raccolto che bisognava infilzare.
Anche Narduccio faceva la sua parte: prendeva le filze e le disponeva in fila vicino al telaietto, pronte per essere appese. Più tardi si ritiravano mio padre, mia madre e Neve, e anche loro si disponevano ai propri compiti. Mio padre si dedicava alla Cucina, preparata da mia madre, che poi prendeva posto assieme a Neve alla filzatura delle foglie.
Si cucinava con la legna. Il camino era nello stesso locale, e spesso il fumo e il caldo del fuoco si facevano sentire. Fuori era cominciato il concerto delle cicale a due, a tre voci: quelle più vivaci ed acute, le più grosse, e quelle più gravi e lente.
Accanto al nostro podere, entrando a sinistra, c'era un Anziano, Leonardo Costantini, denominato Scardaffa. Più in fondo, in un altro podere, c'erano i De Filippis, madre e tre figli scapoli: Pino, Salvatore e Rosina che, spesso, ci facevano compagnia. Avevamo anche una cagna, Massara, che avevamo allevato con molta cura. Ci faceva compagnia e faceva divertire soprattutto Narduccio. Egli aveva l'abitudine di molestarla, soffiandole sul muso. Una volta, indispettita, lo castigò: gli infisse un canino nello zigomo. Noi, nonostante avesse ragione, la picchiammo; essa si accucciò e ci chiedeva quasi scusa. Così trascorrevamo i giorni l'uno dopo l'altro.
Una sera, verso il tramonto, mentre tornavamo a casa, sentimmo scampanio di campane a festa. Era il dieci giugno. Non vi erano ricorrenze in calendario. Si cominciò a chiedere di qua e di là, ma nessuno ci sapeva spiegare quello scampanio a festa. Giunti in paese, si nota un grande movimento di gente che va verso la piazza. Chiediamo il perché di tanta festa e finalmente ci dicono che l'Italia è entrata in Guerra, accanto alla Germania, contro la Francia e l'Inghilterra. I ragazzi, stimolati dai gerarchi fascisti, gridano, urlano, contenti; ma i più anziani, quelli che ricordavano ancora le piaghe della Grande Guerra, invece, si mostrano preoccupati e rattristati. Maggiormente in apprensione erano quei genitori i cui figli prestavano già servizio militare. Di questa categoria faceva parte la mia famiglia. Mia madre cominciò ad essere apprensiva e triste. Scherzava poco; e sera e mattina recitava preghiere per scongiurare il perdurare della Guerra. Noi ragazzini eravamo più spensierati, meno consapevoli e quindi più estranei. Il nostro intento era quello di salire sugli alberi, correre, mangiare, lavorare e divertirci.
Tra notizie di Guerra favorevoli e sfavorevoli alle nostre forze armate, si estinsero anche quei mesi di vacanza scolastica. Ormai era già settembre. Rocco era stato trasferito in Albania, perché si pensava già di portare la Guerra anche su quell'altra sponda. Io, intanto, mi preparavo a rientrare in Istituto.
I Rifugi Antiaerei
Due giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico rientrai in Istituto. Ci fu gran festa nel ritrovarci tra compagni ed amici. Passammo quei due giorni raccontandoci le vicende delle vacanze trascorse: gioie, divertimenti, amarezze, dispiaceri, a secondo dei casi particolari.
Il primo giorno di Scuola ci ritrovammo ciascuno nella propria classe, coi propri compagni. Fui lieto di poter salutare la mia maestra che, come al solito, ci mostrò simpatia, disponibilità e, direi quasi affetto. Era l'anno della terza elementare. La signorina (così chiamavamo la maestra) ci esortò a cominciare l'anno con nuovo impegno, forza di volontà e attenzione. Ci disse che aveva molta fiducia in noi e che non l'avremmo fatta ricredere. Tutti facemmo buone promesse; però non tutti riuscimmo sempre a mantenerle. Alcuni dei nostri compagni, nonostante la buona volontà, non erano dotati di attitudini particolari, e anche il quoziente d'Intelligenza scarseggiava; per cui non riuscivano a rendere un profitto sufficiente. La signorina dedicava tutta se stessa; a volte, forse, trascurava anche un po' i più capaci per portare quelli sulla sufficienza, ma non sempre ci riusciva. Per alcuni l'aritmetica sui cubaritmi era tabù, la geometria un fallimento. Erano carenti di capacità di Orientamento. Noi li chiamavamo "inceppati", perché non si muovevano con disinvoltura. Noi più pronti, invece, giocavamo al pugilato, stando attenti a non colpire in faccia, ma solo sulla cassa toracica. Giocavamo al calcio con una "latta", così chiamavamo il nostro pallone rappresentato da un barattolo di salsa, pestato in modo da renderlo rotondeggiante. Eravamo molto attaccati a quello sport. Ci eravamo divisi in due categorie: quella dei grandi e quella dei mezzani. Io, spesso, per la mia rapidità di spostamento e per la capacità di localizzare con molta precisione il "pallone", ero scelto nelle squadre dei "grandi", nel ruolo di portiere.
Il nostro "campo da giuoco" era la grande terrazza che ci offriva ampi spazi di movimento. Eravamo felici durante le belle giornate, sopratutto perché nel pomeriggio ci conducevano in terrazza, e lì potevamo sbizzarrirci a giocare e a sudare.
Ma poi venne il tempo brutto, non quello meteorologico, ma la Guerra che cominciava a farsi sentire anche da noi. Infatti la "latta" ci rompeva le scarpe, e i superiori cominciavano a proibirci la migliore attrattiva: il Calcio.
Intanto il 28 ottobre di quell'anno scoppiò la Guerra anche in Albania contro la Grecia, e qui cominciano le preoccupazioni: la vita di mio fratello in pericolo. Dopo poco tempo cominciarono i guai anche per noi: di notte fummo svegliati più di una volta dal Suono lugubre delle sirene che avvertivano il pericolo di bombardamenti nemici. Venivamo accompagnati nel rifugio dove ci trovavamo tutti, anche il nostro direttore Giuseppe Fabbri, che era stato inviato a Lecce per coprire il posto vacante. Era un bolognese, molto preparato culturalmente e didatticamente. Possedeva gran proprietà di Linguaggio e di espressione. Per tirarci fuori dalla noia e dalla paura ci raccontava "storie", fiabe, favole, e ci tratteneva in conversazioni. Non abitava in Istituto, ma quando suonava l'allarme, con moglie e figlia, veniva a trovarci. Erano brutti tempi: tutto cominciava a scarseggiare; le notizie sul fronte albanese erano disastrose. I bollettini di Guerra annunciavano perdite di Uomini e mezzi, anche se cercavano di minimizzare. Ma noi tutti eravamo preoccupati. Come se non bastasse, seppi da mia madre che anche mio padre era stato chiamato alle Armi nella riserva con destinazione Taranto. Infatti quando si congedò ci raccontò che assistette, fuori dai rifugi, al bombardamento di aerei inglesi sulla flotta italiana ancorata nel porto di Taranto. Ci diceva che gli aerei scendevano a bassissima quota senza trovare valida resistenza antiaerea e riuscivano a colpire le nostre navi con facilità. Infatti quello fu un brutto colpo per la nostra Marina.
Le vacanze di Natale erano vicine; seppi che Rocco era rimasto ferito da una scheggia di granata ad una mano ed era in infermeria. Mia madre era disperata. Furono le uniche vacanze di Natale che io passai in Istituto. Mia madre venne a trovarmi il giorno di S. Stefano e, per potermi condurre un po' in giro per Lecce, mi dovetti far prestare le scarpe da Michele Chirico, ragazzo di Grottaglie, poichè le mie si erano rotte giocando al calcio. Dopo la passeggiata ci ritirammo in Istituto e si congedò da me. Tutto era triste in quei giorni e il tempo non prometteva nulla di buono.
Passarono le vacanze; passò gennaio e un giorno di febbraio fui chiamato in Parlatorio. Chi c'era? Rocco. Non sto a dire la gioia, la commozione, le lacrime, gli abbracci... e poi:
- Come stai? Sei guarito? -
- Sono stato ferito un'altra volta da schegge anche alla schiena, ma per fortuna in modo non grave. Ora sono in convalescenza . -
Soffrivo e godevo nello stesso tempo, nel pensare che Rocco, allora, non aveva ancora ventuno anni e aveva rischiato per ben due volte la vita per una ragione senza senso, senza alcuna giustificazione, se non quella di pazzia di alcuni Uomini ritenutisi grandi.
La sig.na Dotoli, quando seppe dell'evento, volle mio fratello in classe e si fece raccontare, alla nostra presenza, le vicende dei suoi ferimenti. Era molto sensibile e anche preoccupata perché la sua città natale, Napoli, era mira frequente di bombardamenti nemici. Fu lei stessa a intercedere per me, per una breve vacanza in famiglia insieme con mio fratello. Io fui felicissimo.
Qualche giorno dopo, la nostra Insegnante volle organizzare una visita alla Caserma Trizio in via Monteroni, dove c'erano feriti di Guerra, rimpatriati dall'Albania per lunga convalescenza. Offrimmo ai feriti dei doni e auguri di pronta guarigione. Tornammo in Istituto più contenti e soddisfatti.
I capitoli tratti dall'autobiografia "Un Cieco Che Vede" del prof. Antonio Greco, vengono pubblicati con l'autorizzazione dell'autore. Per contattare il prof. Antonio Greco e per informazioni sull'opera completa si può Scrivere a griconio@gmail.com
