La Carriera Ciclistica - Da “Un Cieco che Vede” del prof. Antonio Greco
Antonio Greco Aggiornato il 14/04/2021 08:00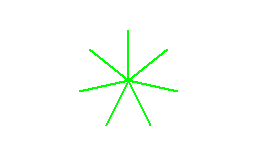
Quei due mesi passarono molto presto e io, con la promozione in tasca, me ne tornai al paese natio. Compagni ed amici furono lieti di potermi riavere tra loro, ma più felice fu Narduccio, col quale avevo cominciato una nuova carriera di attività: la bicicletta. Infatti con Narduccio, che aveva appena cinque anni, seduto sul telaio, mi esercitavo a farmi segnalare ostacoli e segnalazioni per evitarli. Era ormai abbastanza capace di intendere le mie esigenze, dovute ad assenza visiva. Lo tenevo seduto sul telaio della bicicletta, tra le mie braccia che reggevano il manubrio. Egli coi gomiti mi segnalava l'obbligo di spostarmi, col gomito sinistro a sinistra, e col destro a destra. Naturalmente la pressione che egli esercitava sulle mie braccia poteva essere più sollecita o meno a secondo delle circostanze. Per rallentare la corsa, premeva con entrambi i gomiti sulle mie braccia; più forte era la pressione, più energica doveva essere la frenata. Fatta esercitazione sulle strade che già conoscevo bene, allargavo la cerchia delle mie esplorazioni, fino a spostarmi nei paesi più vicini: Melpignano, Martano e anche Maglie. Allora le strade erano semplici. Non c'erano ponti, nè svincoli. Le automobili erano rarissime. Si incontravano solo cavalli con carri. Mi piaceva moltissimo andare in bicicletta e spesso, in seguito, mi impegnavo in gare di velocità con ciclisti occasionali, incontrati sulla strada. Per stimolarli alla gara, bastava superarli; poi rallentare e farsi sorpassare; quindi superarli ancora e continuare poi la gara fino alle prime case del paese. Quasi tutti accettavano la sfida. Nonostante avessi Narduccio sulla bicicletta, molte volte vincevo il contrasto. Sembrava che vedessi, poichè mio fratello non mi rivolgeva nessuna parola che fosse suggerimento di Guida. Tutto avveniva mediante segnali simbolici. Chi non mi conosceva era certissimo che io fossi vedente. Infatti, quando non avevo voglia di fare corse, procedevo ad andatura normale. E spesso capitava di raggiungere altri ciclisti coi quali, qualche volta nascevano delle conversazioni. Più di una volta tali compagni occasionali, rivolgendosi a me, dicevano: "Guarda, guarda, quante olive porta quest'albero. E guarda questi altri! Quest'anno l'"entrata" è buona" E io dovevo fingere di guardare e di annuire.
Ma la prova più difficile era il Percorso della via che conduceva nel nostro podere. Era una strada sconnessa, con sassi e piccoli scogli. Il fondo era segnato da due solchi laterali che nei secoli erano stati scavati dalle ruote dei traini e, al centro, un tratto di strada più uniforme, dovuto al calpestio degli zoccoli dei cavalli. Ai lati, tra i muriccioli a secco e i solchi delle ruote, si presentavano stretti passaggi costeggiati da spine, per i pedoni. Io dovevo ingegnarmi, naturalmente con la bravura di Narduccio, a cimentarmi ora sull'uno, ora sull'altro Percorso. Se distrattamente la ruota della bicicletta finiva in uno dei classici solchi, non c'era speranza che si potesse uscire senza cadere o fermarsi per spostare di peso la bicicletta. Ma io mi ero allenato talmente bene, che tale inconveniente non mi succedeva quasi mai. Tutti i passanti, meravigliati della mia bravura, si facevano la croce e sussurravano: "Gesù, Giuseppe e Maria", come per scongiurare eventuali pericoli che potessero capitare a me e anche al piccolo che conducevo sulla mia bicicletta. Ormai io e Narduccio operavamo in perfetta simbiosi. Mettevo il piede sinistro sul pedale sinistro e, dopo una breve rincorsa, montavo in sella con una dimestichezza da circo.
Vista la mia sicurezza e capacità di conduzione della bicicletta, anche Vito Marini, che ormai mi era sempre vicino, volle provare a sostituire Narduccio. Facemmo brevi esercitazioni e donai anche a lui il "brevetto". Di sera mi spostavo con lui, anche perché Narduccio era ancora troppo piccolo.
Vito Marini
Vito apparteneva ad una famiglia di agricoltori che allora si dicevano possidenti. Infatti possedevano case e qualche podere. Il padre si era risposato per il decesso della prima moglie, da cui aveva avuto una bambina che avviarono al diploma di Insegnante elementare. Dalla seconda moglie ebbe sei figli: il maggiore, Giuseppe, avviato in seminario per gli studi classici, e gli altri cinque, Assuntina, Nzina, Vito, Teresa e Salvatore, si dedicavano alla vita dei campi.
Vito come tornava da campagna, finita la cena, veniva subito da me. Era molto amante della Musica e soprattutto del canto. Possiede ancora una buona Voce di baritono. Io, che lo sapevo contadino, a sentirlo parlare di opere liriche, di cenni di Letteratura, di Poesia, mi meravigliavo come mai un contadino possedesse Cultura più ricca degli altri suoi simili. Gliene chiesi spiegazione, e mi raccontò di sè e della sua famiglia. Mi diceva di avere parenti sacerdoti (ad esempio, padre Chiriatti alla chiesa di S. Luigi a Lecce), che erano molto religiosi e che i suoi avevano donato alla nostra Parrocchia la statua di Santa Veronica. Delle conoscenze teatrali e letterarie mi diceva che suo fratello Giuseppe e sua sorella Maria, la maestra elementare, durante le vacanze estive parlavano di tali argomenti. Così la nostra amicizia di giorno in giorno si rinsaldava sempre più. Le passeggiate in bicicletta, con lui sul telaio, furono sempre più frequenti, ma, ad onor del vero, meno perfette di quelle con Narduccio. Narduccio era insuperabile per la precisione e l'esattezza delle segnalazioni. Naturalmente ero abbastanza pronto anch'io nell'eseguirle con la massima rapidità e prontezza di riflessi. In quegli anni, più che oggi, la gente, giovanotti ed adulti, era solita sostare in piazza nei pomeriggi delle domeniche: chi per incontrarsi con amici, chi per l'esigenza di conversare, chi per trovare Lavoro, poichè chi era in cerca di Lavoro si recava in piazza per mettersi in evidenza ed essere ingaggiato. Insomma la piazza, di domenica pomeriggio, era gremita di persone che formavano tanti capannelli. Io con Narduccio sulla bicicletta, riuscivo, zigzagando, ad attraversare la piazza senza sfiorare qualcuno. Molti mi osservavano e rimanevano attoniti, mentre io, indifferente ed estraneo, mi allontanavo contento e soddisfatto della mia perfettibilità. Con Vito, invece, non tentavo ancora tali imprese, perché conscio di poter fallire. Infatti con lui sulla mia bicicletta o, più in là, sulla sua, ho una Storia da raccontare. Ma sarà oggetto di altro capitolo. Per ora diciamo che Vito ha due anni meno di me, e che suo fratello Salvatore si unirà a noi, con la Voce di tenore, qualche anno più tardi, perché allora era appena di otto anni. La mia abitazione era posta tra due strade parallele e i Marini, per recarsi al loro podere principale, dovevano passare da una di queste due strade; non passavano mai senza fermarsi per salutarmi e per fissare gli appuntamenti serali. Volevano cantare, ma io allora non possedevo nessuno strumento; però approfittammo del fatto che il parroco, rimasto senza organista, mi chiese se volevo suonare le messe. Io accettai e i Marini furono felici di potersi esibire nei canti religiosi accompagnati dall'organo. Ormai mi ero costruito una vita intensa e piacevole. Durante la settimana mi trattenevo in campagna; di tanto in tanto Vito faceva un salto e veniva a trovarmi. Mi canticchiava romanze dal Rigoletto di Verdi, dalla Gioconda di Ponchielli, dall'Elisir d'amore di Donizzetti, ed altre. Nel mio Racconto, direttamente o indirettamente, sarà quasi sempre presente.
Le notti in campagna
Quell'anno, il 1941, era un anno particolare: Rocco era stato trasferito in Sardegna, e noi stavamo più tranquilli, perché, almeno, lì non c'era per il momento la Guerra. Ma mio padre era ancora raffermato a Taranto e quindi in campagna di giorno c'erano soltanto le Donne, compresa mia cognata Carmela, che allora era solo fidanzata di Rocco. La coltivazione del tabacco richiedeva la presenza di persone anche di notte, sopratutto quando il tempo minacciava pioggia. A noi era stato affidato un ragazzo, Uccio Maniglio, perché apprendesse l'arte dell'agricoltore. Suo padre era pescivendolo, e Lavoro per i giovani, esclusa l'agricoltura, non si trovava. Perciò fu affidato a noi, sia per non tenerlo in mezzo alla strada, sia perché imparasse almeno un mestiere.
Era il mese di agosto, e io e Uccio sostavamo in campagna anche di notte per vigilare sul tabacco e sulla raccolta di fichi secchi. Una sera, eravamo verso la fine del mese di agosto, potevano essere le undici di sera; improvvisamente comincia a piovere. Sulla piccola terrazza, su un lenzuolo, erano stesi fichi ad essiccare al sole. Usciamo fuori e ancora è solo pioggerellina. Uccio prende una fune e sale sulla terrazza per chiudere il lenzuolo e legarlo con i quattro angoli alla fune e calarlo a me che dovevo raccogliere il pacco e metterlo al coperto. Intanto la pioggia infittisce, e io lo sprono a far presto. Uccio comincia a calare il fardello. Io, accostato al muro, con le mani protese verso l'alto, attendo. Finalmente l'involucro arriva all'altezza delle mie mani e si ferma. La pioggia continua a cadere. Io gli grido:
- Ucciu, cala! - .
- Sto calando, - mi risponde.
Io cerco di tirar giù il carico, ma questo non cede di un centimetro. Continuo ad urlare:
- Allenta la fune che qui i fichi non scendono! -
Dopo ripetuti "botta e risposta", Uccio grida, infastidito:
- E nnaa! - e mi butta giù tutta la fune, ma il lenzuolo continua imperturbato a rimanere fisso al muro. Grido al compagno di scendere. Curioso, prendo una scaletta, la appoggio al muro e mi arrampico per verificare che cosa possa essere successo. Che era successo? All'altezza di circa due metri nel muro era conficcato un grosso chiodo; il lenzuolo si era impigliato lì e stava bello e tranquillo, mentre noi ci prodighiamo per disincagliarlo. Intanto la pioggia non cessa; anzi aumenta e ci disorienta. Tira di qua e tira di là, il lenzuolo si strappa e tutti i fichi, mezzi secchi, si sparpagliano al suolo, mentre noi ci mettiamo precipitevolissimevolmente al coperto. Peccato! Quella raccolta di fichi andò tutta perduta; e noi, bagnati come spugne e irritati, ci asciughiamo alla meglio, e cerchiamo di prendere sonno. Il lettore (ammesso che ci sarà) potrà meravigliarsi, chiedendosi: come mai Uccio non aveva visto quel chiodo malandrino conficcato nel muro? La risposta non è difficile. In quei tempi tutte le campagne erano sprovviste di illuminazione elettrica. I combustibili per l'illuminazione erano costosi, e quindi di notte, quando non c'era la luna, si faceva ricorso a qualche fiammifero o, male che andasse, al chiarore di una sigaretta accesa.
In quanto a sigarette, anche questo è un argomento interessante: le sigarette di Stato erano scarse e costose per chi vedeva il denaro da lontano. E allora bisognava ingegnarsi. Era proibito consumare tabacco che non fosse di Stato. La guardia di Finanza vigilava; se ti sorprendeva anche con pochi grammi di tabacco coltivato da noi, ma per la Finanza, oggetto di contrabbando, erano dolori. Bisognava pagare forti multe. Però noi in campagna eravamo più al sicuro, poichè quando ci serviva per fare la sigaretta, attingevamo direttamente alla fonte. Ma non era solo questo l'unico problema. Per fare le sigarette servivano le cartine, e anche quelle si acquistavano al tabacchino; però mancavano i Soldi, e perciò bisognava Studiare. Noi aggiravamo l'ostacolo fornendoci di sottili fogli di carta, detta di riso. Li tagliavamo a piccoli rettangoli, grandi quanto le cartine di Stato e fabbricavamo la sigaretta. Quei rettangolini erano sprovvisti di colla, ed ecco trovato il rimedio: latte di fico o miele di fichi, e l'artificio era bello e pronto. Ora bisognava solo fumarlo. Si può immaginare che bel sapore avessero quelle sigarette. Però per noi andava tutto abbastanza bene, e non solo per noi. Quasi tutti i contadini fumatori ricorrevano a quegli espedienti. Ormai la Guerra, col passare del tempo, causava sempre maggiore miseria. Anche i fiammiferi scarseggiavano e bisognava ricorrere alla conservazione del tizzone continuamente acceso, protetto sotto la cenere, come facevano gli antichi.
Tra un Lavoro e l'altro il tempo passava; ormai eravamo alla fine di settembre e bisognava rientrare in Istituto per frequentare la quarta elementare. Questa volta andai più tranquillo, senza la paura delle incursioni aeree, poichè le ostilità con la Grecia erano già terminate e quindi eravamo più al sicuro.
I capitoli tratti dall'autobiografia "Un Cieco Che Vede" del prof. Antonio Greco, vengono pubblicati con l'autorizzazione dell'autore. Per contattare il prof. Antonio Greco e per informazioni sull'opera completa si può Scrivere a griconio@gmail.com
