La Bicicletta - Da “Un Cieco che Vede” del prof. Antonio Greco
Antonio Greco Aggiornato il 10/02/2021 08:00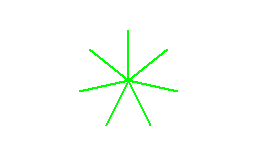
La Bicicletta
Era una bicicletta usata, un po' vecchia, a mozzo fisso che presto sostituimmo con la ruota libera. Nessuno dei miei sapeva andare in bicicletta, e allora incominciò la gara e la corsa per apprenderne la conduzione. Per mio padre era soprattutto un mezzo di necessità, perché con la bicicletta poteva, con minore sforzo e con maggiore vantaggio e rapidità, allargare la cerchia dei Comuni nei quali esercitare il mestiere di ambulante. Tutti volevano provare e, nella maggior parte dei casi, quegli sforzi erano coronati da brillanti cadute. Tuttavia mio padre in breve tempo riuscì a guidare la bicicletta decentemente. Anche Rocco apprese presto le regole del gioco. Le mie sorelle tentarono, ma per il momento pensarono meglio di rinunciare. Rimanevo io che avevo sette anni, e, come se non bastasse, ero anche di statura bassina. Quindi non potevo nemmeno sognarmi di cavalcare la bicicletta. Però gli espedienti non mi mancavano: osservato attentamente il nuovo mezzo, tentai prima di condurlo a piedi; poi provai ad infilare la gamba destra nel triangolo del telaio e a camminare così coi piedi per terra. Infine provai a dare una spinta coi piedi e poi a sollevarmi da terra, facendomi trascinare dalla forza d'inerzia.
Il secondo passaggio fu col piede sinistro sul pedale e col destro, sempre dentro il triangolo del telaio, sospeso; poi piano, piano, cominciai a percorrere alcuni metri con i piedi sui pedali, e alla fine ero diventato così bravo che senza scendere e senza fermarmi, riuscivo a girare intorno al cortile e a ritornare indietro. Allora, di traffico di automobili o veicoli a motore non se ne parlava. Anche le biciclette erano misurate,e io potevo permettermi il lusso di uscire in bicicletta fuori dal cortile per estendere ogni giorno di più le mie scorrerie. Mediante il fruscio della bicicletta riuscivo a tenermi a distanza dai lati della strada, e ad evitare le persone con la percezione dei loro passi o del loro discorrere, se erano in compagnia. Certo, questi privilegi mi erano concessi quando la bicicletta era in casa, altrimenti dovevo dedicarmi ad altre attività ludiche.
Della mia educazione scolastica non si parlava nemmeno. Qualche volta mio padre diceva a mia madre che il proprietario della Lamacina gli diceva che a Castro c'era un giovane il quale era diventato professore di musica, poichè era stato mandato in Istituto per ciechi e lì aveva studiato; ma mia madre non ne voleva sapere. Non voleva allontanarmi dalla famiglia e sopratutto dalle sue cure e premure. Diceva ancora Donato Plenteda a mio padre che egli aveva due figli sacerdoti, Don Beniamino e Don Angelo e che si sarebbero interessati loro del carteggio per farmi entrare in Istituto. Ma non se ne parlò mai concretamente.
Intanto era passato un anno e mezzo dall'acquisto della bicicletta e mio padre, giacché le condizioni economiche erano precarie, decise di arruolarsi per l'Africa Orientale; era il marzo del 1936.
Ricordo che prima di partire da Lecce per Napoli, dove si sarebbe imbarcato per l'Africa, ci facemmo prestare il cavallo col traino e andammo tutti a Lecce. Fungeva da cocchiere lo zio Pasquale, che era stato anche mio padrino. L'animale era di proprietà di Salvatore Mele, marito di "Mescia" Rosa, una bravissima signora. Salvatore era, per quei tempi, un grosso commerciante di stoffe e tessuti e possedeva due cavalli con relativo "traino" (carro agricolo per molti usi). Siccome in casa sua non disponeva di una stalla abbastanza capiente per due cavalli, uno di essi veniva parcheggiato nella nostra stalla, ed era un'altra mia distrazione e motivo di interesse. Riconoscente a questa nostra ospitalità del cavallo a titolo di favore gratuito, ci prestò il mezzo per recarci a Lecce a salutare mio padre in partenza.
Il viaggio fu lungo e snervante. Impiegammo forse più di quattro ore. Ci fu anche qualche piccola sosta forzata, perché si resero necessarie delle riparazioni ai guarnimenti del cavallo. Quando arrivammo a Lecce ci fermammo presso una locanda addetta al parcheggio degli equini; poi ci recammo al distretto militare dove trovammo mio padre con la divisa di Camicia Nera. Entrammo in un grande capannone dove formicolavano diverse attività: chi cuciva vestiti per i militari; chi faceva pulizia. Poi c'era un arrotino che non smetteva mai il suo Lavoro. Chiedemmo a mio padre che cosa facesse e ci disse che affilava baionette, pugnali, sciabole ed altre armi bianche.
Le mie sorelle e mia madre si impressionarono e si commossero pensando che quelle armi potevano servire per uccidere altri simili.
A mezzogiorno mio padre ci mostrò la gavetta col rancio e la borraccia con l'acqua. Ci trattenemmo ancora e poi ci licenziammo da lui con abbracci, baci e lacrime. Ci avviammo alla taverna per riprendere il viaggio di ritorno. Il cavallo riprese il passo del trotto, ma come si avvicinava una automobile (in realtà erano troppo poche), lo zio Pasquale lo accostava al lato della strada e rallentava notevolmente il passo, per riprenderlo subito dopo il passaggio della macchina.
Tutti eravamo un po' tristi, perché avevamo lasciato mio padre, preoccupati che dovesse andare a combattere. Lo zio Pasquale cercava di sollevarci il morale, dicendo battute scherzose ed invitandoci a cantare, poichè allora era di consuetudine che, quando un gruppo di persone stavano insieme, cantassero le canzoni popolari e campagnole. Lo zio per distrarci trovò un argomento importante: la mia Cresima. Infatti egli era stato il mio padrino e ci diceva che quando il vescovo mi diede il classico schiaffetto io, quasi, quasi, stavo per reagire. Infatti quando mi cresimai avevo solo sei anni e qualche mese. Il parroco diceva che le maestre di catechismo gli avevano garantito la mia ottima preparazione. Gli avevano detto che sapevo tutto a memoria e che perciò potevo ricevere il sacramento della Cresima. Mi cresimai il 24 settembre del 1933. Era di domenica. Ma era un giorno senza sole che contrastava con la gioia e la felicità di tutti i fanciulli cresimati. Il clima autunnale si faceva sentire, e io mi ricordai di tutto ciò e anche del regalo che lo zio mi aveva fatto in quella circostanza: mi aveva regalato un bel vestitino. Intanto, parlando del più e del meno, raggiungemmo Martano al Suono delle campane serali.
- Vedete come è bello il mio paese? - Disse mio zio che era nato a Martano. Aveva indovinato l'argomento. Scattò in piedi immediatamente il campanilismo:
- Non senti come suonano brutte le campane? Le nostre, invece, di Castrignano, suonano così belle che sembra una musica! -
Mio zio: - Ma Martano è più grande di Castrignano. -
E Uccia: - Sì, ma con tutte le pecore! -
E così scherzando, arrivammo a Castrignano che era quasi buio. Lo zio sistemò il cavallo nella stalla, ci salutò e se ne andò. I miei entrarono in casa un po' turbati per la mancanza di mio padre. Io uscii nel cortile e, trovati gli amichetti, raccontai loro la cronaca della giornata.
Passammo un po' di tempo giocando e scherzando e poi mi ritirai; mangiai qualcosa, non ricordo bene che cosa, forse pane e olio mescolato ad aceto e successivamente andammo tutti a letto.
Intanto passavano i giorni e mia madre, all'ora della posta, aspettava il passaggio del postino con la speranza di avere notizie di mio padre. Insieme con lui partì anche mio zio Peppino, marito di un'altra sorella di mio padre, Addolorata, per noi zia "Nunna ", perché aveva fatto da madrina al battesimo di mio fratello Rocco. Nè l'uno, nè l'altro sapevano scrivere; quindi dovevano trovare qualche commilitone che ne sapesse più di loro. Infatti passarono parecchi giorni, quando una mattina, verso le 10,30, per la gioia di tutti, il portalettere gridò: - Patisso! - Corremmo tutti verso di lui e ci consegnò una lettera. Mia madre la aprì subito e cominciò a leggercela, giacché da bambina aveva frequentato la seconda elementare. Fummo felici nel sentire che mio padre stava bene e che aveva fatto la traversata da Napoli a Massaua senza pericoli e ci informava che poi dovevano trasferirsi in Abissinia. Diceva anche che aveva trovato dei compagni calabresi e precisamente di Reggio Calabria e che con loro si trovava bene. Così tutti noi ci tranquillizzammo e riapparve nuovamente sulle labbra di mia madre il sorriso.
L'anno prima di partire, mio padre aveva lasciato il fondo Lamacina e si era accordato con Nicola Bianco per un altro fondo di Nome "Petrusa". Questo, rispetto al Lamacina, presentava un punto di vantaggio molto importante: si poteva disporre di una grande cisterna che avrebbe permesso di assicurare in buona parte l'acqua agli ortaggi che, sopratutto per quei tempi, erano molto importanti.
Ora, partito mio padre, io, che avevo già nove anni, decisi di andare in campagna con Rocco, soprattutto per fargli compagnia e anche perché la campagna costituiva per me una grande attrazione. Ormai arrivava la bella stagione: maturavano le fave e i piselli, e provavo gran piacere a raccogliere baccelli di fave e mangiarli in mezzo alle piante. Il frumento era cresciuto abbastanza, ma ancora non c'erano le spighe. Io mi divertivo a sconare mezza piantina dalla quale spezzavo una diecina di centimetri, schiacciavo la parte più molle del fusto e ricavavo le trombette; bastava soffiare e riuscivo a riprodurre un Suono di trombetta: più grosso era il fusto e più grave era la nota che riuscivo a tirar fuori. Altre trombettine riuscivo a ricavare dalle foglie di ulivo: tagliavo per un centimetro circa l'estremità della foglia, poi dalla venatura centrale la spaccavo per quasi un centimetro, la piegavo simmetricamente e, soffiando, riuscivo ad ottenere una nota più acuta di quella ottenuta dai gambi delle piantine di frumento in generale.
In campagna andavamo con la bicicletta di mio padre, dotata di un largo e lungo portabagagli nostrano, costruito cioè dai fabbri locali, quindi abbastanza rustico, ma molto resistente. Io prendevo posto sulla canna orizzontale del telaio. Quella bicicletta rappresentava quasi un piccolo mulo: a volte dalla campagna venivamo su di essa noi e caricavamo anche una bella "sarcina" (fascine di legna) per accendere il fuoco a casa.
Intanto ogni quindici giorni circa arrivava una lettera di mio padre, e mia madre si sedeva vicino alla "tavola" e rispondeva alla missiva. Mio fratello Rocco allora si accorse quanto era importante l'istruzione che da bambino aveva sempre avversato. Infatti riuscì a malapena a finire la seconda elementare. Perciò decise di volere andare a lezione alla "Scuola Serale". Giacché di giorno tutti lavoravano, potevano permettersi questo lusso solo di sera. Scelse la "Scuola Serale" di Antonio Aventaggiato (Ntoni Milleddha), dove altri giovani e meno giovani cercavano di attingere alla cultura. Si facevano concorrenza due scuole serali, in quei tempi: questa di Milleddha e un'altra di Rocco Salvatore (Rocco Mariano). Dalle testimonianze mi risulta che erano entrambi i maestri molto bravi e capaci di inculcare ciò che sapevano nei loro alunni. Infatti forse entrambi i maestri non possedevano più della terza elementare. Mi risulta anche che, mentre Antonio Milleddha dava un'impronta più scientifica al suo insegnamento, sopratutto in matematica, nell'esercizio delle quattro operazioni, Rocco Mariano imprimeva, invece, un carattere più letterario. Ciò risultava soprattutto dalla lettura del celebre libro "Pinocchio"; mi dicevano che cercava di imitare la voce di ogni singolo personaggio e con la mimica lasciava trasparire la sua impronta interpretativa. Erano belli quei tempi! Ogni raccontino ci sembrava un'opera d'arte; ogni favola ci conquistava a tal punto che ci rappresentavamo le immagini, le scene e cercavamo di fare tesoro di ogni detto, di ogni modo di dire. Ricordo, per esempio che mi rimase impresso il detto della favola di Esopo: il lupo e la volpe: "il mondo è fatto a scale; chi scende e chi sale". Erano esercitazioni di lettura di Rocco che io ascoltavo con molto interesse. Anche se non avevo avuto la fortuna di stare in una classe di Scuola, sentivo già il piacere del "sapere" e il gusto dell'apprendere. Mi piaceva dare una spiegazione a tutto ciò con cui venivo in contatto. Volevo rendermi conto di tutto. Ma, naturalmente, arrivavo dove me lo consentiva la mia capacità intellettiva e l'apprendimento ambientale, molto limitato.
Un altro grave problema di questi scolari era rappresentato dal fatto che di giorno dovevano lavorare dal sorgere al tramonto del sole, e di sera dovevano adattarsi alla luce di candela, o di lume ad olio o a petrolio. I lumi a petrolio erano più estetici e più completi, sormontati da una campana di vetro entro la quale stazionava la fiammella.
Di tanto in tanto la scolaresca "serale" faceva festa; questo succedeva spesso di domenica: il maestro, a spese di tutti gli alunni, acquistava un cane. Da premettere che la carne di cane, nonostante tanta miseria e fame, era rifiutata dalla maggior parte della popolazione, anche se c'era una parte di essa che se ne cibava. Infatti il maestro aveva il compito di preparare detta carne con ricette più ghiotte e aromi squisiti, tanto che anche quegli scolari, che magari avrebbero preferito non partecipare, non potevano tirarsi indietro senza essere scherniti. Perciò, volenti o nolenti, tutti partecipavano e consumavano quelle squisite cene.
A proposito di carne di cane, le sorelle di mio padre, zia Lucia e zia Addolorata, mi raccontavano un aneddoto: mi dicevano che una sera di domenica, mentre mio padre era andato a far loro visita, lo invitarono a mangiare con loro un po' di carne di cavallo. Mio padre, credendole sincere, accettò l'invito. Non se ne parlò più, anche perché avevano una certa paura di lui, perché era risoluto nelle sue decisioni. Mi dicevano che dopo quindici giorni si trovò di nuovo da loro e, battuta su battuta, cominciarono a fare: "Hi! Hi! Hi! Vau! Hi, Bbau!" E ridevano tra di loro. Mio padre, irritato, in grico:
- ti lete, iatì nghelute sa fesse? - (che cosa dite, perché ridete come stupide?) E continuavano a ridere. Poi gli facevano: - Era buona la carne di domenica scorsa? -
Allora mio padre capì di che si trattava: lo avevano burlato. Gli avevano offerto carne di cane, pur sapendo che egli non voleva nemmeno sentir parlare. Allora mio padre, scosso e indispettito, uscì nell'orto, si mise le mani in gola per vomitare la carne di cane che aveva mangiato quindici giorni prima. E qui di nuovo le scroscianti risate. Ma dovettero tenersi lontane dal fratello per non buscare qualche regalo per il gentile complimento.
I capitoli tratti dall'autobiografia "Un Cieco Che Vede" del prof. Antonio Greco, vengono pubblicati con l'autorizzazione dell'autore. Per contattare il prof. Antonio Greco e per informazioni sull'opera completa si può scrivere a griconio@gmail.com
