La Prima e la Seconda infanzia - Da “Un Cieco che Vede” del prof. Antonio Greco
Antonio Greco Pubblicato il 03/02/2021 08:00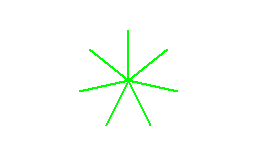
La Prima Infanzia
Vorrei cercare di dare un ordine alle mie memorie a cominciare dai primi anni della mia esistenza; ma non è così semplice, come potrebbe sembrare. Tuttavia cercherò di rendere semplice l'esposizione ed interessante il contenuto.
Il mio estratto di nascita recita che sono nato di venerdì, il 13 del mese di maggio alle ore 23,50 dell'anno 1927 a Castrignano dei Greci in provincia di Lecce. Quello che dirò dei primi tre o quattro anni, è chiaro, che in gran parte lo racconto per sentito dire da parenti e vicini di casa.
Il primo grande dispiacere che provarono i miei familiari, appena nato io, fu quello di avere appreso dalla ostetrica che in buona parte avevo un visus ridotto, come una mia sorella maggiore di nome Donata, per i familiari Uccia. Cominciò così per i miei genitori la trafila presso gli oculisti, in verità allora molto pochi e non disponibili sul luogo. Se si tiene presente poi, che i mezzi di locomozione erano molto scarsi e costosi e che la vita della mia famiglia era una vita contadina svolta solo a mezzadria, si possono meglio capire i disagi che Uccia prima, e io poi, avevamo creato a questi straziati genitori. I soldi scarseggiavano e il Lavoro rendeva appena per potersi sfamare con pane di orzo, quando c'era, e con fichi secchi spesso fino a dopo Natale. Qualsiasi elemento commestibile poteva costituire alimento prezioso.
Io ero nato in una misera casetta di un grande vano, con copertura a canne e tegole, diviso in due da un muro intermedio. La casa era ubicata in un cortile di forma quasi ad imbuto, cioè stretto all'ingresso e allargato verso la fine. Questo cortile si trova in via Vittorio Veneto vicino ad un frantoio oleario che allora era proprietà dei Plenteda.
L'estate scorsa ho potuto rivisitare la mia casetta che, con molta nostalgia e con grande stupore, ho trovato quasi identica. Entrando, di fronte c'è il focolare (Cantuna in greco) (cantune in dialetto); sulla sinistra avevamo una specie di cassapanca che serviva per mille usi e che ancora Uccia custodisce. Sulla destra un lettino sovrastato da uno stipetto ricavato nel muro di pietre e intonacato. Accanto al focolare un piccolo tavolo che serviva da supporto per consumare i pasti. Tra il lettino e la "banca" c'era la porta senza infisso da cui si accedeva alla stanza da letto: sulla destra un tavolino messo ad angolo, poi il comò; a sinistra il letto matrimoniale e in mezzo, tra l'uno e l'altro, la porta d'uscita nel giardino. A sinistra una piccola stalla; a destra il letamaio che si estendeva per la lunghezza della stalla, e poi un piccolo terreno coltivabile di una quarantina di metri quadri con tre alberi di fico, delimitato da muri a secco. I pavimenti dell'abitazione sono fatti in "Chianche", lastre di pietra Leccese.
In questa casetta, modesta, umile e senza conforti particolari, trascorsi la mia infanzia e quasi tutta la fanciullezza, giacché quando cambiammo casa, avevo già 12 anni. Mi raccontavano i miei genitori che fin dalla più tenera età ero molto vivace e sveglio. Mi dicevano che una volta, avevo forse 19 mesi, si era deciso di portarmi a fare visita a Santa Lucia, a Scorrano, in occasione della ricorrenza della festa della santa , con la speranza di qualche miracolo (la speranza è sempre l'ultima a morire). Ebbene, mi dicono che in quattro non riuscivano a vestirmi a festa. Con ciò volevano farmi capire che ero stato sempre impertinente e puntiglioso.
La Seconda Infanzia
I miei primi ricordi si perdono lontani nel tempo e ora si presentano molto flebili e sfumati.
Ricordo che la mattina d'estate i miei si levavano molto presto e verso l'alba eravamo già in viaggio verso il fondo di nome Lamacina che mio padre aveva pattuito a mezzadria con il proprietario Donato Plenteda.
Ero portato in braccio o sulla schiena da mio padre. Quando eravamo in campagna i primi raggi del sole ci accarezzavano devotamente e gli uccelli e i primi insetti ci facevano festa intorno.
In campagna vi era una casetta di un solo vano rettangolare che poteva essere largo tre metri circa e lungo forse cinque. Era molto basso, forse meno di tre metri. A destra si affacciava il camino seguito da un pollaio con due ingressi: uno dall'interno e l'altro dall'esterno. Alla distanza di una trentina di metri era stato ricavato nella roccia un contenitore per l'acqua piovana che doveva servire sia per l'alimentazione che per l'igiene. Tutto intorno alberetti di pesco e molti alberi di fico i cui frutti allora rappresentavano il pane dei poveri.
Ma ora voglio aprire una parentesi: non ho ancora presentato la mia famiglia. Ebbene, eccola: mio padre Pietro Paolo Martino (allora i nomi si appioppavano a dozzine) Greco; mia madre Esterina Patisso; mio fratello maggiore Rocco, seguito da mia sorella Uccia di cui ho già fatto menzione; poi Maria Neve (Neve); infine il sottoscritto. Dopo nove anni dalla mia nascita, mia madre dette alla luce un altro fratellino che per me rappresentò poi la gioia, l'interesse, la premura per la sua crescita e devo dire anche il mio sollievo e la mia liberazione dall'impedimento di potermi muovere da un luogo all'altro. Ma di ciò parlerò in seguito.
Riprendiamo le mie memorie della seconda infanzia. Trascorrevamo tutta l'estate di giorno in campagna e di notte al paese dove, di sera, i vicini si riunivano fuori dalle case all'aria fresca e si dilettavano a raccontarsi a vicenda le loro esperienze, le loro preoccupazioni, le proprie storie. I reduci della grande Guerra (1915-18) si dilettavano, si eccitavano, godevano nel raccontare le imprese, le storie che per ciascuno dovevano essere le più interessanti, le più importanti, le più gloriose. Noi piccoli, spesso durante quei lunghi racconti, ci addormentavamo e le nostre fatine ci conducevano a letto.
D'inverno invece la vita era diversa. In campagna faceva molto freddo; e poi non c'era una ragione che giustificasse la vita all'aperto, in quanto d'estate si coltivava il tabacco e la raccolta dei fichi; mentre d'inverno in campagna bisognava coltivare solo la terra, ed erano lavori esclusivi degli Uomini, anche se venivano impegnate le donne per lavori più leggeri quali la raccolta della verdura e l'annaffiatura. Inoltre molte donne erano impegnate nella lavorazione dei tabacchi nelle ditte locali. Le più importanti per la prima lavorazione di questi tabacchi appartenevano al dr. Giuseppe Monosi (Don Pippi); ai Salvatore (Donn'Affretu) ai Veris di Melpignano e ai Salvatore-Marotta.
Ricordo che la vita era molto dura. Le mamme lasciavano i propri figli più piccoli in custodia ai fratelli o sorelle più grandi. A mezzogiorno queste lavoratrici avevano un'ora di libertà che si riduceva a 40 45 minuti, poichè uscivano dal posto di Lavoro con un po' di ritardo e rientravano in anticipo; quindi, si vedevano ridotto il tempo a loro disposizione. Non sapevano che fare prima: accudire i più piccoli, curare i più grandicelli, lavare indumenti, preparare per la cena, e, in fretta e furia, mangiare un pezzo di pane, quando c'era. Quando faceva troppo freddo noi bambini restavamo in casa presso il focolare a riscaldarci col fuoco, acceso con qualsiasi combustibile allora reperibile. Mio fratello Rocco metteva nel giardino le trappole per i passeri e, come se ne prendeva uno, si faceva tutti festa. Quando invece le giornate erano soleggiate uscivamo nel cortile a giocare, a correre, a tirare sassolini, spesso a fare dispettucci alle nonne che se ne stavano beatamente al sole. Così trascorrevano le giornate e le stagioni. Intanto era arrivata un'altra estate, e una vicina di casa, la Rosina Donno sposata ad Antonio De Franciscis, ci affidò una capra, giacché noi potevamo condurla al pascolo nella nostra campagna. Era arrivato per me un altro divertimento. Mi accorsi che ero molto affezionato agli animali. Volevo starle sempre vicino; tenerla per la catena, la cui estremità, fissata ad un palo, le permetteva un buon raggio d'azione per pascolare. Quando la sera tornavamo a casa volevo condurla solo io; però ero piccolo e la capra mi trascinava; allora doveva intervenire Rocco o mio padre per darmi una mano.
Poi arrivò l'inverno, periodo di nascita degli agnelli e dei capretti. Era, mi pare, il mese di dicembre, quando in un pomeriggio uscii nel giardino per bisogni fisiologici, poichè allora non disponevamo di lussuosi bagni. A nostra disposizione c'era il giardino in fondo al quale vi era una fossa biologica. Di notte, invece, ci servivamo di vasi di metallo, denominati "pisciaturi" e di vasi di creta più grandi chiamati "càntari". Ma ritorniamo al mio pomeriggio: La capra quel giorno era rimasta a casa. Mi affaccio nella stalla e che vedo? La capra brucare foglie di verdura e intorno ad essa due piccoli animaletti tutti brio che le passano sotto il ventre; si fermano; poi riappaiono. Dopo ho saputo che avevano cominciato a succhiare il latte dalla madre che sembrava tutta felice. Alzava la testa, mi guardava e poi tornava a consumare la sua verdura. Ricordo che, impietrito, stupefatto e curioso, rimasi ad osservare. Ma la gioia, l'entusiasmo, la novità mi svegliarono da quell'incanto e tornai in casa dove non c'era nessuno; allora uscii nel cortile . Qui trovai le mie sorelle con le amiche vicine di casa. Raccontai loro che nella stalla vi era la capra con altri due animaletti che non conoscevo. Esse mi fecero una lunga risata di ironia, quasi di scherno; però le mie insistenze destarono la loro curiosità e vennero ad accertarsi. Fu per tutti una meraviglia, poichè non avevano nemmeno loro mai visto due bei capretti appena nati. Corsero alla proprietaria dell'animale per informarla del lieto evento, e per tutto quel pomeriggio, fino a sera, quando tornarono tutti dalla campagna, si fece gran festa.
Ma, ahimè! Le gioie, purtroppo, non durano mai per lungo tempo. Dopo alcuni giorni la capra ci fu tolta. Non so se fu mio padre o la padrona a volersene disfare. Io rimasi scioccato da quel distacco. Come se avessi perduto una persona cara. Rimasi per parecchi giorni ammutolito; privo della mia proverbiale vivacità. Andavo nella stalla con la speranza di poter trovare la mia amica. Ma la delusione aggravava la mia situazione. I miei genitori se ne erano accorti; ma non riuscivano a trovare un diversivo che potesse farmi dimenticare quella amicizia perduta.
Finalmente una domenica, di pomeriggio, mio padre si era recato a Cannole a far visita a sua sorella Donata, sposata in quel Comune. Tornò a casa prima del tramonto del sole, e, meraviglia tra le meraviglie, che mi porta? Un bel cagnolino nero che cominciò subito a giocare con me. Mi leccava le dita, si metteva supino e, con le zampette anteriori, le metteva in bocca, fingendo di mordere, ma in realtà voleva solo giocare. Non avevo mai giocato con un cagnolino, ma era come se lo avessi tenuto da sempre. Cominciò a tornare il mio entusiasmo e la mia vivacità. Quando il cagnolino si fece più grande, di tre o quattro mesi, cominciammo le gare di velocità nel cortile, ma se il cane non riusciva o non voleva superarmi, si appendeva con i dentini ai miei pantaloncini e spesso me li strappava. E qui cominciavano le lagnanze di mia madre che aveva poco tempo per rattoppare i danni prodotti da Moro, questo è il nome che gli avevamo dato. Intanto la mia simbiosi continuava e i nostri giochi diventavano sempre più frequenti e più complessi; Moro si era fatto grande ed era molto affezionato alla famiglia; prediligeva starmi sempre vicino. Si prestava a tutti i miei giochi, anche a quelli che lo volevano vittima del mio egocentrismo di bambino. Lo mettevo in castigo e il mio martire mi obbediva accucciato ai miei piedi. Si alzava tutto scodinzolante ad un mio cenno verbale meno severo del precedente; e così passavano i giorni e i mesi anche con lui.
Se gli mancavo per un po' di tempo, al mio ritorno non sapeva più che festa farmi: mi saltava addosso; si buttava a terra; poi correva per invitarmi a inseguirlo; ritornava e mi girava intorno finchè non mostravo di prestargli attenzione. Ma la vita non era fatta solo di giochi...
Mia sorella Uccia, causa la pertosse, aveva subito danni alla vista e a volte mia madre conduceva me e lei da un oculista di Galatina per visite periodiche. Ai disagi economici per le spese di viaggio e per l'onorario all'oculista, che allora, 1933 o 32, era di venti lire a visita, a una delle ultime visite si aggiunse il dolore di mia madre che per parecchi giorni vedevo prostrata e triste. Dopo seppi che l'oculista le aveva riferito la diagnosi secondo cui il mio occhio destro si sarebbe ingrossato a dismisura (cosa che non si verificò mai). Naturalmente non si disponeva quasi mai di moneta suonante e si doveva pagare il viaggio con beni di natura: farina, grano, piselli, orzo ed altro di cui potevano disporre i contadini. Però per l'oculista doveva trovarsi denaro in contanti e lì aumentavano i sacrifici. I miei genitori volevano cercare di non far progredire la cecità mia e di Uccia. Io infatti possedevo un residuo visivo che mi permetteva di cogliere le immagini dai libri, i colori, di cui ora ricordo solo i fondamentali: rosso, bianco, diverse sfumature di verde ed altre sensazioni cromatiche che ora, cieco totale, non riesco più ad identificare. Infatti le cure dell'oculista condussero Uccia alla cecità totale. Io invece conservavo ancora il mio residuo visivo, quando un giorno d'estate, forse il mese di luglio, poichè ricordo che faceva molto caldo, mi avvicinai all'uscio della casa di fronte alla mia che era abitata dalla famiglia Chirivì Filomeno. L'ingresso era sbarrato da una fascia di legno alta circa 80 centimetri; serviva ad ostruire l'uscita a una diecina di pulcini che avevano comprato in mattinata. All'interno stava anche il figlio Giuseppe, un anno più piccolo di me. Alla mia vista chiese a sua madre di voler uscire per giocare con me. Sua madre sollevò l'asse di legno per farlo passare da sotto. Io ero intento ad osservare quei pulcini che si muovevano continuamente beccando qua e là, quando d'improvviso sento un forte dolore nell'occhio sinistro. Giuseppe, alzandosi di scatto, dopo che era uscito carponi, inconsapevolmente mi aveva colpito con la testa nell'occhio. Io misi tutt'e due le mani sull'occhio e scappai a casa mia, dove non c'era nessuno. Quando venne mia madre, che era andata sul Comune per firmare lo stato di disoccupazione, mi trovò rannicchiato, con le mani che coprivano gli occhi e si spaventò. Mi chiese subito che cosa era successo, e io le raccontai l'accaduto. Si informò presso la comare Ntina che era la mamma di Giuseppe, ma lei non se ne era nemmeno accorta. Cercarono di mettermi acqua fresca, pensando che poi mi sarebbe passato. La cosa durò per due o tre giorni; in seguito mio padre che, tra l'altro, nei giorni in cui era meno impegnato con la campagna, esercitava anche il mestiere di ambulante di bottoni, cotone, mollette per capelli, nastri ed altro, andando a fare rifornimento di merce presso l'Insegnante Antonio Greco il quale aveva rifiutato l'insegnamento per dedicarsi al commercio, mio padre, dicevo, decise di comprarmi una palla di gomma, con l'intento di spingermi al movimento e al giuoco, sicuro che avrei trascurato il dolore dell'occhio. Allora di medici non se ne parlava nemmeno. Vigeva la medicina spicciola, fatta di esperienze e conoscenze casarecce. In verità, il movimento della palla mi attrasse e mi distrasse; ma quando i miei mi osservarono attentamente videro che l'occhio era stato danneggiato irrimediabilmente. Non sto a descrivere le scene di sconforto, di dolore e di pianti: Ormai avevo perduto definitivamente quel residuo visivo che mi era stato tanto prezioso fino a quel giorno.
Furono momenti anche per me di sgomento, di paura, di sconforto, di disorientamento e di sfiducia. Per parecchi giorni mi sforzavo di pensare alle mie cose che avevo abbandonato; ma buon sangue non mente. Piano, piano, cominciai a cercare i miei giocattoli che, per la verità, in quei tempi erano molto modesti. Mi accorsi che non era poi tutto compromesso: cominciai ad ambientarmi, a muovermi, e anche con una certa disinvoltura. Convogliai l'armamentario ludico dei miei giocattoli e mi sforzai di riprendere quella attività che da un po' di tempo avevo trascurato.
La Fanciullezza
Ormai ero diventato grandicello; avevo più di sei anni e già da tempo preferivo i giuochi sociali a quelli individuali, anche se non rinunciavo nemmeno a questi. Infatti i miei giuochi si alternavano dalla trottola al "mazzarune". I giocattoli di cui disponevo erano i seguenti: due trottole in legno "lu fitu", una grande e l'altra piccola; un vecchio cerchione di bicicletta che spingevo con un fuscello di olivo, riuscendo ad imprimergli il senso di marcia da me desiderato. Inoltre giocavo anche con un cerchio di metallo ricavato da un tripiede, supporto di pentole sul fuoco. Questo veniva spinto da un ferro di ombrello alla cui estremità foggiavamo una staffa di cavallo, piegata ad angolo retto rispetto al manico. L'incedere di questo cerchio generava anche un Suono piacevole. L'attrezzatura per il gioco del "mazzarune" consisteva in una striscia di legno lunga circa 40 centimetri, larga una diecina e di spessore quasi due centimetri.
Ma oltre a questi giochi praticavamo altri privi di qualsiasi attrezzatura quali il "trifinizzi", la "Bella, bella insalatina", il gioco dello "Mpuzzare" che consisteva nel piegarsi ad angolo retto e costituire una fila di quattro o cinque ragazzini di due squadre che gareggiavano nel saltare con maggiore disinvoltura e abilità sulle schiene della squadra piegata ed appoggiata al muro; quando si commetteva qualche errore si alternavano i ruoli.
Così, tra un giuoco e l'altro, tra una distrazione e l'altra, passavo i miei giorni, e, ad essere sincero, mi ero ambientato talmente bene, che quasi non mi accorgevo della mia menomazione. Si era sviluppato in me tanto il senso dell'Orientamento e della localizzazione, che nemmeno i miei compagni di giuoco mostravano di accorgersi della mia situazione. Cominciavo a sentire l'attrazione verso le mie coetanee che più di una volta ingenuamente e istintivamente abbracciavo. Ci volevamo tutti bene. Era quella l'età dell'innocenza, così bella, così poetica. Ci sembrava di possedere tutto il mondo, poichè eravamo uguali nelle aspirazioni e nel possesso di cose. Si giocava spensieratamente senza esigenze particolari e senza l'assillo di problemi importanti. Ricordo che non eravamo esigenti; accettavamo di buon grado le scelte dei nostri genitori che, in base alle loro esigenze, decidevano di condurci da una zia, da uno zio e così via. Stavamo dappertutto bene; e in campagna, quando non c'era altro, vi erano gli alberi; era sufficiente che con le mani riuscissi ad afferrare un ramo e già ero sull'albero. Ero diventato molto agile e forte, anche perché i nostri passatempi erano tutti di movimento.
Ma la mia attività ginnica si arricchì quando mio padre decise di comprare la prima bicicletta.
I capitoli tratti dall'autobiografia "Un Cieco Che Vede" del prof. Antonio Greco, vengono pubblicati con l'autorizzazione dell'autore. Per contattare il prof. Antonio Greco e per informazioni sull'opera completa si può scrivere a griconio@gmail.com
